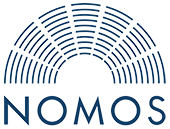Dazi USA, l’Europa prende tempo e Lagarde avverte sugli effetti economici
La Commissione europea rinvia a metà aprile l’entrata in vigore delle contromisure contro i dazi americani, nel tentativo di evitare un’escalation commerciale e guadagnare margini per aprire un negoziato con Washington. Lo ha annunciato il commissario al Commercio Maroš Šefčovič davanti all’Europarlamento, spiegando che l’Unione attenderà di conoscere nel dettaglio le tariffe “reciproche” che gli Stati Uniti intendono applicare dal 2 aprile. Il primo pacchetto di dazi europei, inizialmente previsto per l’inizio del mese su whisky, barche e motociclette americane, sarà dunque posticipato alla metà di aprile, quando dovrebbe entrare in vigore anche una seconda tranche di misure contro altri prodotti Made in USA.
La scelta europea risponde alle pressioni di diversi governi, tra cui Francia, Spagna e Italia, che hanno chiesto prudenza e dialogo, per evitare una spirale di ritorsioni. “No a dazi contro dazi”, ha detto pochi giorni fa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre il premier francese François Bayrou ha definito un errore colpire il whisky americano, temendo ritorsioni su beni sensibili come champagne e vini europei, minacciati da tariffe fino al 200%.
Secondo la presidente della BCE Christine Lagarde, una guerra commerciale con gli Stati Uniti potrebbe costare fino a mezzo punto di Pil all’eurozona. Intervenendo al Parlamento europeo, Lagarde ha spiegato che l’imposizione di dazi americani al 25% sulle merci UE taglierebbe la crescita di tre decimi nel primo anno, mentre una risposta “occhio per occhio” da parte dell’Unione porterebbe il danno fino a cinque decimi. Le conseguenze colpirebbero non solo la crescita, ma anche l’inflazione, che potrebbe aumentare di mezzo punto percentuale, complicando ulteriormente la gestione dei tassi d’interesse da parte della BCE. Lagarde ha ribadito che la Banca centrale agisce “riunione per riunione” senza impegni anticipati, vista l’incertezza eccezionalmente alta del momento. I tassi sono stati tagliati al 2,5% a inizio marzo e il prossimo aggiornamento è previsto proprio a metà aprile, in coincidenza con l’avvio delle misure europee.
Sul fronte americano, la situazione non è meno tesa. La Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati i tassi, ma il presidente Jerome Powell ha avvertito che i dazi potrebbero rallentare ulteriormente la crescita USA e spingere l’inflazione, già in risalita. Il presidente Trump, intanto, ha aumentato la pressione sulla Fed, chiedendo via social un taglio immediato dei tassi: “Ora che i dazi cominciano a colpire, fate la cosa giusta”, ha scritto su Truth.
Secondo le stime BCE, l’effetto negativo dei dazi sarà persistente, anche se decrescente nel tempo, e potrebbe indebolire ulteriormente la produzione industriale europea. Le previsioni di crescita – già modeste – indicano uno 0,9% nel 2025, l’1,2% nel 2026 e l’1,3% nel 2027. Prospettive che, alla luce del nuovo contesto, potrebbero essere riviste al ribasso. Infine, anche le prospettive d’inflazione restano fragili. Al netto dell’effetto dazi, la dinamica dei prezzi nell’eurozona sta lentamente rallentando: dal 2,5% di gennaio al 2,3% di febbraio. Le stime della BCE vedono un’inflazione media al 2,3% nel 2025, in discesa fino all’1,9% nel 2026 e al 2% nel 2027. Ma se la guerra commerciale dovesse esplodere, questo equilibrio potrebbe saltare.
Draghi: “Competitività, energia, difesa. L’Europa agisca come uno Stato unico”
Di fronte alle Commissioni congiunte di Camera e Senato, Mario Draghi ha delineato con chiarezza la necessità di un cambio di passo radicale per rafforzare la competitività dell’Europa, mettendo in guardia da un futuro fatto di marginalità economica, dipendenza tecnologica e irrilevanza geopolitica. Nel corso dell’audizione sul Rapporto sul futuro della competitività europea, l’ex presidente del Consiglio ha lanciato un appello forte all’unità politica ed economica dell’Unione, sollecitando i parlamentari a guardare oltre i confini nazionali: “L’Europa deve agire come uno Stato unico, con un mercato integrato, una strategia industriale comune e un debito condiviso”.
Il punto di partenza è il divario crescente con gli Stati Uniti: il reddito disponibile europeo è oggi la metà di quello americano, e negli ultimi cinque anni i consumi in UE sono cresciuti appena del 2%, contro il 13% degli USA. Le cause? Secondo Draghi, una debolezza strutturale del sistema industriale europeo, la frammentazione del mercato interno e un ritardo preoccupante negli investimenti in tecnologia e innovazione, in particolare nell’intelligenza artificiale, dove l’Europa non sviluppa nessuno dei dieci modelli più avanzati al mondo. A preoccupare è anche la crescente vulnerabilità commerciale e geopolitica dell’UE, che dipende per il 50% del suo PIL dal commercio estero, contro il 26% degli Stati Uniti. Le politiche protezionistiche di Washington, la competizione cinese e il disallineamento fiscale e normativo tra Stati membri rischiano di mettere fuori gioco le imprese europee. Draghi ha invocato una strategia industriale più solida che sappia distinguere tra tecnologie già perse (come i pannelli solari), settori da tutelare per l’occupazione (come l’acciaio) e ambiti strategici ad alta innovazione (come batterie e clean tech), che vanno protetti da concorrenza sleale e sostenuti con regole, incentivi e capitali.Uno dei nodi più critici resta l’energia: Draghi ha denunciato come, tra settembre e febbraio, il prezzo del gas in Europa sia aumentato in media del 40%, con punte del 65%, e che l’elettricità in Italia costi fino all’87% in più rispetto alla Francia. Ha quindi proposto l’uso coordinato del potere d’acquisto europeo, lo sviluppo delle rinnovabili e il disaccoppiamento dei prezzi dell’energia verde da quelli fossili, oltre alla necessità urgente di sbloccare gli iter autorizzativi per i nuovi impianti.Altro fronte centrale è la difesa europea. L’invasione dell’Ucraina e la minore attenzione strategica degli USA hanno reso urgente, secondo il Rapporto, un piano da 800 miliardi di euro per rafforzare la sicurezza comune. Draghi ha sottolineato la frammentazione e l’inefficienza dell’attuale sistema europeo, che spende molto ma ottiene poco, con il 65% delle importazioni militari provenienti dagli USA. Per questo, ha rilanciato l’idea di una difesa integrata, con sinergie industriali, interoperabilità tra eserciti e investimenti in tecnologie dual use, digitali e di cybersecurity.
Nel corso del dibattito, numerosi parlamentari hanno sollevato questioni cruciali, tra cui il rischio che l’eccessivo focus sul riarmo sottragga risorse a welfare, ricerca e transizione ecologica (Fratoianni), la necessità di regolamentare l’intelligenza artificiale senza frenare l’innovazione (Matera), il rilancio delle PMI nel mercato unico (Gasparri e Paita) e il potenziale ruolo dell’Italia nella difesa e nello sviluppo industriale europeo (Bonetti, Gelmini, Misiani). Alcuni, come Calenda e Faraone, hanno proposto di affidare l’iniziativa della difesa a un nucleo ristretto di Paesi, in una logica a più velocità. Altri, come Borghi e Turco, hanno messo in discussione l’impostazione del piano UE, criticando il rischio di debito eccessivo o di extraprofitti per le lobby della difesa.
In replica, Draghi ha ribadito che la sovranità europea oggi è più efficace se condivisa. Per finanziare le nuove sfide ha indicato il debito comune come strumento chiave, ricordando che, come negli Stati Uniti con i Treasury Bill, un mercato dei capitali integrato non può esistere senza un’attività finanziaria congiunta. Ha anche evidenziato l’importanza di superare il principio dell’unanimità, almeno in materia di politica estera e difesa, e di puntare su cooperazioni rafforzate o trattati intergovernativi per evitare stalli decisionali.
“Il futuro dell’Europa si gioca oggi”, ha concluso Draghi, indicando quattro assi strategici: più innovazione e tecnologia, un mercato unico realmente funzionante, una difesa comune credibile e un debito europeo a sostegno delle sfide comuni. Solo così, ha detto, sarà possibile affrontare con successo la transizione ecologica, garantire sicurezza e restituire fiducia ai cittadini europei, oggi sempre più esposti a disuguaglianze sociali, crisi globali e all’avanzata delle forze anti-europee.
Elkann: “Stellantis punta sull’Italia, ma l’auto europea è sotto pressione”
In un’audizione molto attesa davanti alle Commissioni congiunte di Camera e Senato, il presidente di Stellantis, John Elkann, ha delineato il presente e il futuro del gruppo in Italia, ribadendo l’impegno per il Paese con 2 miliardi di investimenti nel 2024 e un ruolo centrale nella filiera automotive europea. Ma il quadro che ha tracciato è anche carico di preoccupazioni: la competitività dell’industria automobilistica europea è in crisi, tra costi di produzione superiori del 40% rispetto alla Cina, ritardi infrastrutturali e incertezze normative sulla transizione energetica.
Elkann ha ricordato che dal 2004 al 2023 sono stati prodotti in Italia 16,7 milioni di veicoli per un valore di 700 miliardi di euro, con un indotto di 417 miliardi. “Stellantis – ha detto – ha investito 53 miliardi in ricerca e sviluppo, a fronte di 1 solo miliardo di contributi pubblici”, sottolineando il peso strategico dell’azienda nell’innovazione tecnologica italiana. Nel 2024, Stellantis risulta il primo depositante di brevetti industriali nel Paese.
Ha poi presentato un piano dettagliato per gli stabilimenti italiani: Pomigliano (nuova Panda ibrida), Melfi (sette nuovi modelli, anche elettrici), Cassino (nuove Giulia e Stelvio), Mirafiori (Fiat 500 elettrica e dal 2024 anche ibrida), Termoli (produzione di cambi elettrificati e ipotesi Gigafactory), Atessa (veicoli commerciali e camper), Modena (sviluppo Maserati). Un piano articolato, che però si scontra con dati preoccupanti: la produzione in Italia è calata del 62% rispetto al 2017, il mercato europeo è in contrazione da vent’anni, e la transizione elettrica fatica a decollare nei grandi Paesi come Italia, Germania e Spagna, dove le vendite di EV si fermano al 17%.
Il nodo più critico resta la competitività europea nel confronto con l’Asia. La Cina conta 214 gigafactory contro le 13 europee, mentre i costi energetici in Europa sono fino a cinque volte superiori, scoraggiando la localizzazione di impianti strategici come le fabbriche di batterie. Elkann ha ammesso che la Gigafactory a Termoli è in forse proprio per questo motivo, e ha ricordato che in Francia gli incentivi pubblici hanno reso gli investimenti più sostenibili.
Molte sono state le sollecitazioni critiche da parte dei parlamentari, che hanno espresso preoccupazione per l’occupazione, la delocalizzazione e la riduzione degli impegni industriali in Italia. Appendino (M5S) ha chiesto chiarezza su investimenti e riconversione militare, mentre Schlein (PD) ha parlato della necessità di una strategia industriale europea strutturata. Calenda (Azione) ha denunciato il mancato rispetto degli impegni presi da Stellantis – in primis quello della piena occupazione – e ha chiesto se la produzione della Panda possa tornare in Italia. Bagnai (Lega) e altri hanno criticato la strategia “solo elettrica” e l’alleanza con Leapmotor, temendo ricadute su marchi storici come Alfa Romeo e Lancia. Sul piano politico, molti hanno chiesto se il Governo debba intervenire per abbassare i costi energetici e sostenere il settore come già fatto in altri Paesi europei. È emersa anche una forte contrarietà alla riconversione dell’industria automobilistica verso la difesa, proposta ventilata in ambienti istituzionali. In replica, Elkann ha riconosciuto che il 2025 sarà un anno difficile, ma ha indicato nel 2026 – con il lancio di dieci nuovi modelli – una svolta possibile. Ha sottolineato che Stellantis manterrà una pluralità di motorizzazioni (termiche, ibride ed elettriche) e ha confermato l’impegno a rafforzare la filiera italiana, citando l’organizzazione di una convention europea con i fornitori. Sul fronte fiscale, ha assicurato che le imposte vengono versate “in coerenza con la localizzazione dei profitti”, mentre in tema di protezionismo ha osservato che il settore sta virando verso modelli chiusi, come quello brasiliano, dove Stellantis è già leader grazie all’uso di biocarburanti.
Il Governo utilizza e utilizza il Golden Power sui semi italiani
Una riunione d’urgenza, convocata un’ora prima con un solo punto all’ordine del giorno e durata appena quindici minuti, è bastata al Consiglio dei ministri per varare un provvedimento che punta a proteggere i semi italiani attraverso l’attivazione del golden power, lo strumento straordinario di difesa degli asset strategici nazionali. Sul tavolo di Palazzo Chigi, dove la premier Giorgia Meloni era assente ma regista della mossa, un’iniziativa del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per blindare la filiera agroalimentare da possibili acquisizioni straniere e assicurare prezzi sostenibili per le imprese italiane. Secondo fonti di governo, il provvedimento ha ricevuto il via libera con prescrizioni specifiche per l’operazione in questione, i cui dettagli restano riservati ma che coinvolge direttamente la produzione nazionale di sementi. Obiettivo: evitare che un settore cruciale per la sovranità alimentare e la tenuta occupazionale venga compromesso da interessi esterni, soprattutto in un momento in cui il controllo delle sementi è al centro di un delicato equilibrio geopolitico.
Il golden power nel settore agricolo non è una novità assoluta: il precedente risale all’ottobre 2021, quando il governo Draghi intervenne per bloccare l’acquisizione di Verisem B.V. da parte della cinese Syngenta, su segnalazione del ministro Patuanelli. In quel caso, Coldiretti aveva espresso pieno sostegno al provvedimento, avvertendo che due semi su tre erano già in mano a quattro multinazionali straniere e che l’operazione avrebbe ulteriormente spostato in Asia il baricentro del controllo globale sulla produzione di ortaggi ed erbe aromatiche.