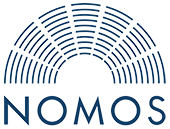Lagarde a Davos: verso un mercato unico dei capitali e pronta ai dazi Usa
Al World Economic Forum di Davos, la presidente della Bce Christine Lagarde ha tracciato una visione ambiziosa per il futuro economico dell’Europa, sottolineando la necessità di accelerare sulla creazione di un mercato unico dei capitali per rilanciare la competitività del continente. «Il 2025 può essere l’anno della svolta», ha dichiarato Lagarde, evidenziando che, a parte due o tre Stati membri ancora restii, si registra un nuovo consenso politico a favore di questa priorità strategica. Lagarde ha accolto positivamente l’intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che a Davos ha posto il mercato unico dei capitali al centro delle politiche per rafforzare le imprese europee. Tuttavia, la presidente della Bce ha insistito sull’importanza di tradurre queste intenzioni in azioni concrete, invitando la Commissione a definire un piano operativo con risultati misurabili entro la fine dell’anno.
Sul fronte globale, Lagarde ha avvertito che l’Europa deve prepararsi ad affrontare le sfide del nuovo protezionismo annunciato dal presidente statunitense Donald Trump, che ha minacciato l’introduzione di nuovi dazi sulle esportazioni europee. «Dobbiamo essere pronti a rispondere in modo adeguato e proporzionato», ha affermato, aggiungendo che il dialogo con gli Stati Uniti deve proseguire, ma che la Ue è pronta a difendere i propri interessi economici se necessario. A rafforzare il messaggio è stato il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis, che ha confermato la determinazione dell’Unione nel proteggere le sue imprese.
Lagarde ha anche fatto riferimento al rapporto Draghi, un documento che delinea piani e priorità per il rilancio della competitività europea, e che, secondo il vicecancelliere tedesco Robert Habeck, è stato sottovalutato in Germania a causa di pregiudizi nei confronti dell’autore italiano. «Non abbiamo più tempo da perdere», ha dichiarato Habeck, invitando i decisori politici europei a leggere e attuare le indicazioni contenute nel rapporto.
Infine, sul fronte economico interno, Lagarde ha annunciato segnali incoraggianti: l’Europa è ben posizionata per raggiungere l’obiettivo di inflazione al 2% entro il 2025. Per quanto riguarda i tassi di interesse, la presidente della Bce ha confermato una politica di tagli graduali, specificando che il tasso naturale si colloca attualmente tra 1,75% e 2,25%, con l’intento di mantenerlo il più basso possibile per sostenere l’economia senza compromettere gli obiettivi di stabilità. Con queste prospettive, Lagarde ha ribadito che il 2025 rappresenta un’opportunità cruciale per trasformare il mercato europeo e affrontare con forza le pressioni esterne, ponendo le basi per un’Europa più competitiva e resiliente.
Le stime grigie del Fondo Monetario Internazionale nel 2026
Il dodicesimo rapporto del Fondo Monetario Internazionale (FMI) offre una visione articolata sulle dinamiche economiche globali, evidenziando una crescita prevista al 3,3% nel 2025 e nel 2026, al di sotto della media storica del 3,7% registrata tra il 2000 e il 2019. Tale previsione riflette un panorama economico caratterizzato da percorsi divergenti e rischi significativi, sia a breve che a lungo termine.
Negli Stati Uniti, l'economia si conferma robusta, con una crescita attesa del 2,7% nel 2025, sostenuta da un forte consumo privato, mercati del lavoro stabili e investimenti in accelerazione. Il contesto è favorito da condizioni finanziarie accomodanti e politiche economiche meno restrittive. Di contro, l'eurozona affronta difficoltà persistenti, con una crescita modesta dell'1% nel 2025, penalizzata dalla debolezza del settore manifatturiero, esportazioni di beni in calo e un'incertezza geopolitica che pesa sulla fiducia degli investitori.
La Cina, nonostante un lieve miglioramento rispetto alle previsioni precedenti, presenta una crescita del 4,6% nel 2025. Questo dato è influenzato da un rallentamento nei consumi interni, persistenti difficoltà nel mercato immobiliare e una bassa fiducia dei consumatori. L'India si distingue come l'economia emergente più dinamica, con una crescita stabile al 6,5%, sostenuta da un'espansione industriale e investimenti pubblici.
Altre regioni emergenti mostrano andamenti misti: in America Latina, la crescita accelera leggermente al 2,5%, mentre l'Africa sub-sahariana vede una ripresa più marcata, grazie a politiche fiscali espansive e una maggiore domanda di materie prime. In Medio Oriente e Asia Centrale, la crescita è prevista al 3,6%, con revisioni al ribasso per Paesi come l'Arabia Saudita, colpita dai tagli alla produzione OPEC+.
L'inflazione globale continua a scendere, attestandosi al 4,2% nel 2025 e al 3,5% nel 2026, grazie al raffreddamento dei mercati energetici e al progressivo rallentamento della domanda. Tuttavia, permangono sacche di inflazione elevata in alcune economie emergenti, dove fattori idiosincratici, come shock alimentari e crisi valutarie, aggravano la situazione. Nei Paesi avanzati, l'inflazione core si sta avvicinando agli obiettivi delle banche centrali, ma resta sopra il 2% negli Stati Uniti e in diverse nazioni europee, mantenendo alta l'attenzione sui tassi di interesse.
Le politiche monetarie divergono: la Federal Reserve mantiene un approccio cauto, con tassi di interesse più elevati rispetto agli altri Paesi avanzati, mentre la Banca Centrale Europea e la Bank of Japan adottano un allentamento più rapido per sostenere la crescita. Questa divergenza amplifica i movimenti dei tassi di cambio, rafforzando il dollaro e aumentando la pressione sui mercati emergenti, che devono affrontare deflussi di capitali e svalutazioni valutarie. Le tensioni geopolitiche e l'incertezza legata alle politiche commerciali continuano a rappresentare una minaccia per la crescita globale. Nuove tariffe e restrizioni commerciali potrebbero penalizzare ulteriormente gli investimenti e distorcere i flussi commerciali. L'FMI stima un rallentamento del volume del commercio mondiale al 3,2% nel 2025, riflettendo sia il contesto protezionistico che i cambiamenti strutturali nelle catene di approvvigionamento globali.
A queste sfide si aggiungono i rischi derivanti dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina, che potrebbero destabilizzare ulteriormente i mercati delle materie prime e aumentare i prezzi di energia e alimenti. Paesi importatori di materie prime, in particolare nelle economie emergenti, potrebbero affrontare uno scenario di stagflazione, con crescita stagnante e inflazione elevata.
Le criticità del sistema previdenziale italiano
Il Dodicesimo Rapporto sul Sistema Previdenziale Italiano, curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, fornisce un quadro dettagliato sull'andamento economico e demografico delle pensioni e dell'assistenza in Italia per il 2023. La spesa pensionistica totale ha raggiunto 267,1 miliardi di euro, in crescita del 7,88% rispetto ai 247,6 miliardi del 2022. Questo incremento è stato determinato principalmente dall'adeguamento delle pensioni all'inflazione e dall'aumento dei pensionati, frutto di misure di prepensionamento introdotte negli ultimi dieci anni. Questi fattori hanno contribuito a un saldo negativo tra entrate e uscite di 30,4 miliardi di euro, simile a quello del 2021 (-30 miliardi), ma in netto peggioramento rispetto al 2022 (-22,6 miliardi). Le entrate contributive nel 2023 si sono attestate a 236,7 miliardi di euro, con un aumento nominale del 5,2% rispetto all'anno precedente. Questo incremento è attribuibile principalmente alla crescita del numero di lavoratori attivi e all’aumento delle retribuzioni, grazie ai rinnovi dei contratti nazionali che hanno parzialmente recuperato l’inflazione. Tuttavia, nonostante il miglioramento delle entrate, il sistema pensionistico continua a presentare disavanzi significativi. Le gestioni pubbliche, in particolare quelle relative ai dipendenti statali, hanno registrato un saldo negativo di 44 miliardi di euro, aggravato dal crescente numero di pensionati e dal peso delle rivalutazioni.
Nonostante il quadro complessivo, alcune gestioni obbligatorie dell'INPS si sono dimostrate sostenibili, contribuendo a mitigare il deficit totale. Tra queste, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) ha registrato un attivo di 15,1 miliardi di euro, mentre la Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati ha prodotto un saldo positivo di 8,6 miliardi. Questo risultato è dovuto principalmente al limitato numero di pensionati e agli importi contenuti delle prestazioni erogate. Anche le Casse dei liberi professionisti, regolate dai decreti legislativi 509/94 e 103/96, hanno mantenuto un saldo complessivo positivo di 4,3 miliardi, grazie al buon rapporto tra iscritti attivi e pensionati.
Il sistema pensionistico italiano continua a essere influenzato da significativi fattori demografici. La crescita dell’età media della popolazione e l’aumento dei pensionati rispetto ai lavoratori attivi rappresentano una delle principali criticità. Nel 2023, il numero totale di pensioni erogate è stato di 17,375 milioni, in leggero aumento rispetto all’anno precedente (+0,07%). Questo dato, sebbene contenuto, sottolinea la necessità di politiche che incentivino l’occupazione giovanile e una maggiore partecipazione al mercato del lavoro.
L’alta inflazione del biennio 2022-2023 ha avuto un impatto rilevante sul sistema previdenziale. Le pensioni sono state rivalutate per adeguarsi ai prezzi, con incrementi particolarmente significativi per i trattamenti minimi (+8,1%). Tuttavia, le pensioni superiori a quattro volte il minimo sono state soggette a tetti di perequazione, generando un risparmio stimato di 3,6 miliardi di euro per il 2023. Nonostante ciò, molti pensionati hanno subito una perdita di potere d’acquisto, soprattutto nelle fasce di reddito più alte, dove il calo ha superato il 10% negli ultimi due anni.
Tim vince in Appello, respinta la richiesta di sospendere il rimborso miliardario
La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il ricorso della presidenza del Consiglio, che chiedeva la sospensione del rimborso di quasi un miliardo di euro a Tim, relativo a un canone indebitamente versato nel 1998. La sentenza, emessa il 20 gennaio, conferma quanto stabilito in precedenza, ovvero che lo Stato deve restituire a Tim la somma originaria di 528 milioni di euro, ricalcolata con interessi e rivalutazioni a un totale di 995 milioni di euro.
Nonostante l’invito della Corte a trovare un accordo transattivo, le parti non sono riuscite a raggiungere un’intesa entro la scadenza fissata. L’offerta avanzata dal legale di Tim, Romano Vaccarella, prevedeva uno sconto di 150 milioni di euro e un pagamento rateizzato del residuo, ma non ha ricevuto risposta da parte dello Stato.
La vicenda ha avuto immediate ripercussioni sul titolo di Tim a Piazza Affari, che inizialmente ha registrato un rialzo del 2,5%, raggiungendo 0,267 euro per azione, per poi stabilizzarsi con un guadagno dell’1,31%. Lo Stato, intanto, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, adducendo come motivazione principale la difficoltà di reperire liquidità per un pagamento integrale immediato.
Nel ricorso, la presidenza del Consiglio sottolinea che una spesa di tale portata inciderebbe in modo significativo sulle finanze pubbliche. Si evidenzia che la somma contestata rappresenta il 2,8% della manovra finanziaria 2024, che prevede complessivamente 28 miliardi di euro di spesa. Il governo ritiene che il pagamento immediato danneggerebbe il bilancio dello Stato, costringendo a modifiche legislative sulle previsioni di cassa già stabilite.
Se il pagamento non verrà effettuato entro il 3 aprile 2024, data della pubblicazione della sentenza, scatteranno ulteriori interessi annuali pari a quasi 25 milioni di euro, aggravando ulteriormente l’onere per lo Stato. La vicenda, quindi, non solo pesa sulle casse pubbliche, ma rappresenta anche un nodo complesso per la gestione finanziaria del governo e il rapporto con un’importante azienda strategica come Tim.
Con il ricorso in Cassazione ancora pendente e l’assenza di un accordo transattivo, il contenzioso resta aperto, lasciando intravedere nuovi sviluppi su un caso che intreccia giustizia, economia e finanze pubbliche.