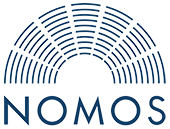Trump minaccia dazi contro l’Europa: l’Italia tra i Paesi più esposti
Donald Trump torna all'attacco del commercio internazionale annunciando nuovi dazi del 25% sulle auto, semiconduttori e farmaci, nel tentativo di ridurre il deficit commerciale con l'Europa, che ha definito un sistema creato per "fregare gli Stati Uniti". L’ex presidente americano ha ribadito il suo "amore" per il Vecchio Continente, ma ha minacciato ritorsioni: «Se provano a rispondere, possiamo semplicemente smettere di comprare da loro». I numeri raccontano però una realtà diversa: il deficit commerciale con l’UE, secondo i dati ufficiali, ammonta a 157 miliardi di dollari, ben lontano dai 300 miliardi citati da Trump. Per l'Italia, gli effetti di questa politica protezionistica potrebbero essere significativi: secondo il centro studi di Confindustria, i settori più colpiti sarebbero bevande (39%), autoveicoli (30,7%) e farmaceutica (30,7%), con un impatto potenziale sull’intero comparto manifatturiero, per cui gli Stati Uniti rappresentano il 7% delle vendite totali. Le simulazioni di Prometeia stimano che l’aumento dei dazi potrebbe costare all'Italia tra 4 e 7 miliardi di dollari, a seconda dell’intensità della misura. L’export italiano verso gli USA, che nel 2024 ha raggiunto i 65 miliardi di dollari, rischia così di subire un duro colpo, con ripercussioni che potrebbero manifestarsi già dal 2026.
UE mette 100 miliardi per l’industria green e meno burocrazia
L’Unione Europea rafforza il proprio impegno nella transizione ecologica con il Clean Industrial Deal, un piano da 100 miliardi di euro per sostenere la decarbonizzazione dell’industria, ridurre i costi dell’energia e semplificare la burocrazia. Presentato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il Summit europeo dell’industria ad Anversa, il piano si propone di garantire che la transizione verde non penalizzi la competitività delle imprese europee in un contesto di crescente concorrenza globale. L’obiettivo è fornire strumenti finanziari alle aziende per modernizzare le infrastrutture produttive e favorire l’adozione di tecnologie a basse emissioni. La strategia include la creazione di una Banca per la decarbonizzazione, finanziata con 20 miliardi di euro dal Fondo per l’innovazione, 30 miliardi di contributi volontari degli Stati membri, 33 miliardi provenienti dal sistema ETS per il periodo 2028-2037 e 2,5 miliardi dal programma InvestEU, con un effetto leva che consentirà di superare la soglia dei 100 miliardi di euro.
Parallelamente, il commissario per il Clima Wopke Hoekstra ha fissato l’obiettivo di ridurre le emissioni industriali del 30%, con un focus sulle industrie energivore e sul settore del clean-tech, ritenuto cruciale per la trasformazione industriale europea. Un altro pilastro del piano riguarda l’abbassamento dei costi dell’energia, un fattore determinante per la competitività delle imprese. Il piano d’azione per un’energia abbordabile, illustrato dal commissario Jørgensen, punta a garantire un risparmio di 45 miliardi di euro nel 2025, che saliranno progressivamente a 130 miliardi entro il 2030 e 260 miliardi entro il 2040, grazie a una revisione della tassazione sull’elettricità che permetterà di ridurre le imposte fino ad azzerarle per famiglie e imprese ad alta intensità energetica. La Commissione intende inoltre completare l’Unione dell’energia, considerata essenziale per garantire una maggiore stabilità dei prezzi nel medio e lungo periodo. In parallelo, il pacchetto Omnibus, presentato dai commissari Dombrovskis e Albuquerque, introduce misure di semplificazione burocratica per le imprese, esentando oltre l’80% delle aziende europee dagli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità e alleggerendo la normativa sulla tassonomia per gli investimenti sostenibili. In particolare, solo le grandi imprese con oltre 1000 dipendenti e un fatturato superiore ai 450 milioni di eurosaranno tenute alla rendicontazione obbligatoria, mentre per le altre sarà prevista una segnalazione volontaria. Vengono inoltre snellite le procedure per la rendicontazione della sostenibilità aziendale, la responsabilità ambientale e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), che verrà reso più efficiente pur mantenendo un controllo sulle emissioni industriali. Il Clean Industrial Deal rappresenta una risposta alle nuove sfide globali, tra cui la crescente concorrenza di Stati Uniti e Cina, e mira a rafforzare la competitività dell’industria europea, garantendo al tempo stesso una riduzione strutturale dei costi energetici e una maggiore sicurezza delle forniture.
Industria in crisi, il governo cerca soluzioni tra tensioni interne e risorse limitate
Di fronte ai pessimi dati dell’industria italiana, il governo sta tentando di correre ai ripari con un decreto mirato a contrastare gli effetti del rincaro dell’energia, ma tra annunci vaghi, difficoltà economiche e attriti tra ministri, il cammino appare incerto. Il cosiddetto “decreto Bollette”, annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al Senato il 13 febbraio, è nato più per rispondere alle critiche di immobilismo che per una strategia ben definita. L’urgenza dell’intervento è dettata dai numeri allarmanti diffusi dall’ISTAT, che certificano un calo della produzione industriale del 7,1% a dicembre rispetto allo stesso mese del 2023, il peggior risultato in quasi due anni di contrazione continua. Nel complesso, il 2024 si è chiuso con una flessione del 3,5%, peggiorando rispetto al già difficile 2023. Particolarmente colpiti il settore automobilistico (-23,6%), il tessile (-18,3%) e il metallurgico (-14,6%), mentre l’intero comparto manifatturiero ha registrato un calo dell’8,7%.
Nonostante le difficoltà industriali siano un problema diffuso in tutta Europa, l’Italia si distingue negativamente. I dati di Eurostat mostrano che, mentre la media europea ha registrato un calo dell’1,7% a dicembre, l’Italia ha segnato un crollo molto più netto, persino superiore a quello della Germania (-4%), tradizionalmente indicata come il grande malato economico del continente. Se la Spagna ha addirittura visto una crescita del 2,6%, l’Italia si trova in una condizione particolarmente fragile.
Il governo Meloni, attento soprattutto alla tenuta dei conti pubblici e alle politiche di sostegno ai redditi medio-bassi, ha trascurato gli interventi a favore delle imprese e degli investimenti produttivi. Lo ha sottolineato più volte Confindustria, che nella sua analisi sulla legge di bilancio di novembre aveva denunciato la quasi totale assenza di misure a sostegno della crescita industriale. Le difficoltà del comparto sono dovute anche a fattori strutturali, come la scarsa produttività, la fuga di giovani laureati, l’inefficienza burocratica e il costo dell’energia più alto rispetto ad altri Paesi europei. Tuttavia, la mancanza di un’azione incisiva da parte del governo ha reso ancora più complicata la situazione, soprattutto in un contesto internazionale che si sta deteriorando, anche a causa della politica protezionistica annunciata da Donald Trump, il cui ritorno alla Casa Bianca potrebbe inasprire le difficoltà per l’export italiano. Le promesse fatte negli ultimi mesi dal ministro Adolfo Urso, titolare delle Imprese e del Made in Italy, e dallo stesso Giorgetti, secondo cui ci sarebbero state svolte positive, sono state smentite dai dati. Per rispondere alle critiche, l’esecutivo ha individuato come priorità il contenimento del costo dell’energia, che colpisce non solo le imprese ma anche le famiglie, con il rischio di alimentare malcontento sociale. Secondo le rilevazioni ufficiali, a dicembre il prezzo dell’energia elettrica e del gas è aumentato del 3,6% rispetto all’anno precedente, una tendenza destinata a proseguire nei prossimi mesi. Il rincaro ha un effetto a catena: bollette più care per i cittadini, maggiori costi di produzione per le impresee, di conseguenza, un aumento dei prezzi dei beni di consumo. Per evitare che questa spirale comprometta ulteriormente la ripresa economica, il governo sta lavorando a un decreto che dovrebbe essere approvato entro l’inizio di marzo. Il tema è stato discusso martedì in un incontro tra la presidente Giorgia Meloni, Giorgetti, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e quello degli Affari europei Tommaso Foti, da cui è stato escluso Adolfo Urso, che non ha nascosto il suo disappunto. Il ministro delle Imprese, che in passato aveva promosso interventi controversi come i controlli sui prezzi della benzina, aveva avanzato delle proposte che, almeno per il momento, non sono state prese in considerazione. Le ipotesi al vaglio riguardano principalmente due direttrici. Da un lato, l’ampliamento dei bonus sulle bollette, alzando la soglia di reddito per permettere a più famiglie di beneficiare degli sconti su luce e gas. Dall’altro, l’introduzione di agevolazioni più consistenti per le imprese, con l’obiettivo di ridurre l’impatto del caro energia sui costi di produzione. Un’opzione su cui si sta lavorando riguarda l’estensione dell’energy release a tutte le piccole e medie imprese, una misura finora riservata solo alle aziende più energivore. Il meccanismo prevede che le imprese possano usufruire di energia a prezzi calmierati per tre anni, a patto di impegnarsi a installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l’obbligo di restituire allo Stato l’energia prelevata nei successivi venti o trent’anni. Si tratta, di fatto, di un prestito energetico a lungo termine, che consentirebbe di sostenere le imprese senza impattare immediatamente sul bilancio pubblico. Tuttavia, restano due nodi da sciogliere. Il primo riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, poiché le risorse a disposizione sono limitate. Il secondo è il rischio che la Commissione Europea possa considerare le agevolazioni per le imprese come aiuti di Stato illegittimi, mettendo a rischio l’intero impianto del decreto. Proprio per evitare uno scontro con Bruxelles, il ministro Foti sta conducendo un negoziato con la commissaria europea alla Concorrenza Teresa Ribera, nella speranza di ottenere il via libera dell’UE.
Saipem e Subsea7 si fondono e nasce Saipem7
La società italiana Saipem e la norvegese Subsea7 hanno raggiunto un accordo per una fusione che darà vita a Saipem7, un colosso nel settore delle infrastrutture energetiche. La nuova società avrà sede a Milano e sarà quotata sia alla Borsa di Milano sia a quella di Oslo. La governance sarà condivisa tra i dirigenti delle due aziende, mentre la fusione è stata accolta positivamente dagli investitori e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Attualmente ENI e Cassa depositi e prestiti detengono rispettivamente il 20% e il 12% di Saipem, ma con la fusione vedranno la loro partecipazione ridursi al 10% e al 6%della nuova entità.
Ok della Camera al Ddl sui lavoratori azionisti
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla governance aziendale, con 163 voti favorevoli, 40 contrari e 57 astenuti. Il testo, nato da una proposta di iniziativa popolare della Cisl, introduce misure per il coinvolgimento diretto dei dipendenti nelle imprese, tra cui la possibilità di entrare nei Consigli di sorveglianza e di amministrazione, la distribuzione degli utili aziendali con un’imposta agevolata del 10% fino a 5.000 euro annui e i piani di azionariato con assegnazione volontaria di azioni ai lavoratori.
Tuttavia, il provvedimento ha suscitato forti critiche da parte delle opposizioni, che lo definiscono “svuotato” rispetto alla versione originale. Il Pd accusa la maggioranza di aver trasformato il diritto alla partecipazione in una concessione delle aziende, mentre il M5S e Avs lamentano il mancato riconoscimento di un ruolo più incisivo per i lavoratori. L’iter legislativo non è ancora concluso: il ddl passa ora al Senato, dove dovrà affrontare ulteriori discussioni.
- Trump minaccia dazi contro l’Europa: l’Italia tra i Paesi più esposti
- UE mette 100 miliardi per l’industria green e meno burocrazia
- Industria in crisi, il governo cerca soluzioni tra tensioni interne e risorse limitate
- Saipem e Subsea7 si fondono e nasce Saipem7
- Ok della Camera al Ddl sui lavoratori azionisti