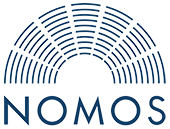Salgono i dazi su Canada, Messico e Cina ma crollano le Borse americane
L’amministrazione Trump ha ufficialmente dato il via a una nuova guerra commerciale, imponendo dazi su 1.500 miliardi di dollari di importazioni da Canada, Messico e Cina. A partire dal 4 marzo, le tariffe su beni provenienti dai due partner nordamericani sono fissate al 25%, mentre per la Cina l’aumento arriva al 20%, con conseguenze immediate sui mercati finanziari globali. Le Borse europee e americane hanno reagito con forti ribassi: il Ftse Mib ha perso il 3,41%, trascinato al ribasso da Stellantis (-10,16%), Stmicroelectronics (-8,37%) e Iveco (-7,73%), mentre a Wall Street il Dow Jones è sceso di 662 punti (-1,53%), lo S&P 500 ha bruciato 90,31 punti (-1,54%), cancellando tutti i guadagni post-elettorali, e il Nasdaq ha perso 252 punti (-1,37%).
Trump ha difeso la sua strategia protezionistica con un messaggio su Truth Social: «Niente dazi per chi sposta la produzione negli Stati Uniti», un chiaro invito alle imprese a delocalizzare all’interno dei confini americani. Tuttavia, le reazioni internazionali non si sono fatte attendere. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato una controffensiva immediata, imponendo dazi del 25% su 107 miliardi di dollari di merci statunitensi. I primi 20 miliardi saranno tassati subito, mentre gli altri 87 miliardi seguiranno entro tre settimane. Trudeau ha definito la decisione di Washington «ingiustificata», avvertendo che avrà conseguenze anche per gli americani, a partire dal settore automobilistico del Michigan, che rischia il blocco delle forniture di nichel ed energia elettrica dall’Ontario. La risposta della Cina non si è fatta attendere: Pechino ha annunciato un aumento dei dazi fino al 15% su prodotti agricoli americani come pollo, grano, mais e cotone, mentre ha avviato un nuovo ricorso presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), accusando gli Stati Uniti di violazione delle regole internazionali. Tuttavia, il WTO si trova in una situazione di paralisi dall’epoca del primo mandato di Trump, il che rende improbabile una risoluzione rapida della disputa. Più prudente la reazione del Messico, che per ora evita un’escalation immediata. La presidente Claudia Sheinbaum ha dichiarato di voler cercare una soluzione negoziata e ha rimandato qualsiasi contromisura alla telefonata con Trump prevista per giovedì prossimo. Gli analisti ritengono che la Casa Bianca potrebbe fare marcia indietro sui dazi imposti al Messico, considerando l’alta integrazione economica tra i due Paesi e i rischi per la competitività americana.
Nel frattempo, la Commissione Europea ha espresso preoccupazione per gli effetti destabilizzanti della decisione di Trump, avvertendo che «questa escalation potrebbe interrompere il commercio globale in un momento cruciale per la cooperazione internazionale». Gli economisti temono un impatto diretto sui consumatori statunitensi, con un aumento dei prezzi nei supermercati, nei distributori di carburante e nelle farmacie, mentre gli effetti economici sulle catene di approvvigionamento nordamericane rischiano di tradursi in una contrazione della crescita. Questa nuova offensiva commerciale di Trump segna un ritorno aggressivo alla politica dei dazi, già sperimentata nel suo primo mandato, con il rischio di scatenare una spirale di ritorsioni internazionali. Se le tensioni non si risolveranno rapidamente, le ripercussioni potrebbero estendersi oltre il settore manifatturiero, colpendo la crescita globale e acuendo le divisioni tra gli alleati occidentali.
Von der Leyen lancia un piano da 800 miliardi per la difesa comune
L’Europa accelera sul riarmo con il piano ReArm Europe, annunciato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen a due giorni dal vertice straordinario sulla difesa del 6 marzo. L’iniziativa prevede un investimento complessivo fino a 800 miliardi di euro, articolato in una serie di misure volte ad aumentare la capacità di difesa degli Stati membri e a rafforzare il sostegno all’Ucraina. «Viviamo in tempi pericolosi, la sicurezza dell’Europa è minacciata come mai prima d’ora», ha dichiarato von der Leyen, sottolineando la necessità di una risposta tempestiva e coordinata.
Il piano si basa su cinque punti principali, tra cui l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di Stabilità, che consentirà agli Stati di aumentare la spesa per la difesa senza incorrere in procedure per deficit eccessivo. Se i governi dell’UE aumentassero il budget militare dell’1,5% del PIL, si creerebbe uno spazio fiscale di 650 miliardi di euro in quattro anni. Il secondo pilastro riguarda 150 miliardi di euro di prestiti agli Stati membri per investimenti in difesa, con l’obiettivo di migliorare le capacità paneuropee in settori strategici come difesa aerea, missilistica, artiglieria, droni e sistemi anti-drone. Il terzo punto prevede l’uso di fondi di coesione europea per aumentare la spesa militare, offrendo flessibilità nei bilanci nazionali. Infine, il piano punta a mobilitare il capitale privato, accelerando l’Unione del risparmio e degli investimenti, e a coinvolgere la Banca Europea per gli Investimenti nel finanziamento del riarmo.
Von der Leyen ha evidenziato la necessità di ridurre i costi e la frammentazione della difesa europea, favorendo acquisti congiunti per garantire maggiore interoperabilità tra le forze armate dei Paesi membri. Il piano risponde anche alla crescente incertezza geopolitica, accentuata dal congelamento degli aiuti militari statunitensi all’Ucraina, deciso da Donald Trump e accolto con favore da Vladimir Putin e dal premier ungherese Viktor Orbán. «Non possiamo più permetterci di dipendere unicamente dagli Stati Uniti per la nostra sicurezza», ha avvertito von der Leyen, riconoscendo il ruolo storico di Washington nella stabilità europea, ma sottolineando al tempo stesso la necessità di un’autonomia strategica dell’UE.
Economia italiana tra rigore di bilancio e crescita debole
Il report pubblicato dall’ISTAT il 4 marzo offre un quadro contrastante sull’andamento dell’economia italiana, mettendo in luce da un lato un miglioramento degli equilibri di finanza pubblica e dall’altro segnali preoccupanti per la crescita del PIL e l’andamento dell’indebitamento. Se da una parte il governo di Giorgia Meloni può vantare una gestione del bilancio più rigorosa del previsto, dall’altra emergono evidenti criticità legate alla scarsa vitalità del sistema produttivo, alle difficoltà nel sostenere gli investimenti e all’aumento della pressione fiscale, che contraddice gli obiettivi dichiarati dall’esecutivo.
Nel 2024, l’economia italiana è cresciuta dello 0,7%, tre decimi in meno rispetto alle previsioni del governo, che nel Piano strutturale di bilancio presentato a settembre aveva stimato un incremento dello 0,9%. Seppur non drammatica, questa revisione al ribasso solleva dubbi anche sulla crescita del 2025, per cui l’esecutivo ha previsto un aumento del PIL dello 0,8%. Con un’economia che rallenta, il rischio è quello di dover rivedere le previsioni finanziarie e di bilancio, con possibili impatti sulle future manovre economiche.
Dove invece il governo ha superato le aspettative è nella riduzione del deficit, che nel 2024 è sceso al 3,4% del PIL, meglio del 3,8% concordato con la Commissione Europea e nettamente al di sotto del 7,2% registrato nel 2023. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una forte contrazione della spesa pubblica, che nel 2024 si è ridotta del 3,6%, principalmente a causa della sospensione progressiva degli incentivi per il Superbonus, il controverso programma di agevolazioni edilizie introdotto dal governo Conte II. La spesa per contributi agli investimenti è infatti crollata del 72,9%, solo in parte compensata dall’aumento della spesa corrente (+3,9%), dovuto soprattutto agli effetti dell’inflazione. Se il miglioramento del deficit è un punto a favore del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha adottato una linea prudente in contrasto con la retorica sovranista della destra, il debito pubblico continua invece a salire. Secondo l’ISTAT, nel 2024 il rapporto debito/PIL è salito al 135,3%, meno del 135,8% previsto dal governo, ma comunque in crescita rispetto al 134,8% del 2023. Inoltre, la spesa per interessi sul debito è aumentata del 9,5%, sottraendo risorse che potrebbero essere impiegate per investimenti in settori strategici come sanità, istruzione e innovazione. L’altro dato che mette in difficoltà il governo è quello sulla pressione fiscale, salita al 42,6% del PIL, in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto al 2023 e di 0,9 punti rispetto al 2022, quando Meloni è entrata in carica. Questo significa che il prelievo fiscale è oggi più alto rispetto a quando la destra ha vinto le elezioni, smentendo le promesse fatte in campagna elettorale. A trainare questa crescita sono stati l’IRPEF e l’IRES, con un aumento delle imposte dirette del 6,6%, mentre anche le imposte indirette, come l’IVA e l’IRAP, sono cresciute del 6,1%.
Occupazione record in Italia, ma il mercato del lavoro resta fragile
I dati pubblicati dall’ISTAT sul mercato del lavoro di gennaio 2025 confermano una tendenza positiva avviata dal 2021: mai così tanti occupati in Italia da quando esistono le serie storiche, con un tasso di disoccupazione ai minimi e un numero crescente di persone impiegate. Tuttavia, dietro questi numeri apparentemente incoraggianti, permangono problemi strutturali profondi, che rendono il mercato del lavoro italiano ancora molto fragile rispetto a quello degli altri paesi europei.
A gennaio, il tasso di disoccupazione è sceso al 6,3%, vicino al minimo storico del 6% registrato a novembre, con un calo di quasi 4 punti percentuali rispetto all’inizio del 2021. Gli occupati hanno raggiunto quota 24,2 milioni, con un incremento di 2 milioni in tre anni e di 500 mila rispetto a gennaio 2024. L’aumento più marcato riguarda i lavoratori maschi, che ora sono 14 milioni, mentre la componente femminile resta pressoché invariata attorno ai 10,2 milioni. La crescita occupazionale è stata favorita da due fattori principali: da un lato, il rimbalzo dell’economia dopo la crisi pandemica ha incentivato le aziende ad assumere; dall’altro, l’invecchiamento della popolazione e l’innalzamento dell’età pensionabile hanno allungato la permanenza nel mondo del lavoro.
Tuttavia, analizzando il tasso di occupazione, che misura quanti lavorano rispetto alla popolazione in età da lavoro (15-64 anni), emergono i limiti strutturali del mercato italiano. Nonostante il record del 62,8%, il nostro paese resta il fanalino di coda dell’Unione Europea: secondo Eurostat, nel terzo trimestre del 2024 l’Italia era l’ultimo paese per quota di occupati, con un distacco di oltre 20 punti percentuali dai Paesi Bassi, il primo in classifica. Il divario è ancora più evidente nel tasso di occupazione femminile, che in Italia è fermo al 53,5%, il più basso d’Europa, con una differenza di 25 punti rispetto ai Paesi Bassi, dove la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è nettamente più alta. Un altro aspetto critico è il numero degli inattivi, ovvero le persone che non lavorano e non cercano attivamente un impiego. A gennaio erano 12,4 milioni, con un tasso di inattività del 32,9%, in calo di 0,5 punti rispetto a un anno fa e di quasi 4 punti rispetto al 2021. Nonostante la tendenza positiva, l’Italia continua a registrare un livello di inattività molto più alto rispetto alla media europea, con una forte disparità di genere: il tasso di inattività femminile è del 42,2%, quasi il doppio di quello maschile (23,6%).
Infine, l’altra grande criticità riguarda gli stipendi, storicamente tra i più bassi in Europa. Secondo uno studio della Banca Centrale Europea, la crescita dell’occupazione in Italia sarebbe stata incentivata proprio dal basso costo del lavoro: mentre i prezzi aumentavano a causa dell’inflazione, le retribuzioni sono rimaste stagnanti, riducendo il potere d’acquisto dei lavoratori. Pur con qualche recente miglioramento, gli stipendi italiani non hanno ancora recuperato la perdita di valore dovuta all’aumento del costo della vita negli ultimi quattro anni.
In sintesi, i dati record sull’occupazione non significano che il mercato del lavoro italiano sia in salute. Se da un lato il numero di occupati è ai massimi storici, dall’altro l’Italia resta ultima in Europa per tasso di occupazione, in particolare femminile, ha un alto numero di inattivi e salari tra i più bassi del continente. Il problema non è solo quante persone lavorano, ma in quali condizioni lo fanno e con quali prospettive di crescita economica e professionale.