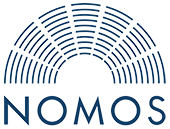Nuovi dazi decisi da Trump ma l’obiettivo finale è il riequilibrio del dollaro
Donald Trump ha aperto un altro fronte delle tariffe doganali, annunciando dazi del 25% su acciaio e alluminio e introducendo l’inedito concetto di “dazi reciproci”, con l’obiettivo di colpire le importazioni da quei Paesi che impongono tariffe sui beni americani. La mossa mira a riequilibrare la bilancia commerciale statunitense, storicamente in deficit, e a proteggere l’industria nazionale. Tuttavia, dietro questa decisione potrebbe celarsi un obiettivo ancora più ampio: le tariffe doganali non sono soltanto un mezzo per limitare l’ingresso di merci estere a basso costo, ma anche uno strumento di politica monetaria per correggere la sopravvalutazione del dollaro, un fattore che da decenni penalizza la competitività dell’industria manifatturiera americana.
Le nuove tariffe colpiranno duramente il Canada, principale fornitore di acciaio e alluminio degli Stati Uniti, ma avranno un impatto significativo anche su Messico e Cina. L’annuncio della Casa Bianca ha immediatamente innescato tensioni diplomatiche ed economiche. Pechino ha reagito con l’imposizione di dazi tra il 10 e il 15% su carbone, gas naturale liquefatto, petrolio e attrezzature agricole americane, oltre a una stretta sull’export di metalli rari, essenziali per la produzione di batterie e tecnologie avanzate. Il governo cinese ha inoltre avviato un’indagine su Google per presunte violazioni antitrust, un segnale di come la disputa commerciale possa rapidamente estendersi ad altri settori. Tuttavia, l’impatto delle contromisure cinesi appare più limitato rispetto all’offensiva tariffaria statunitense: le nuove tariffe di Pechino colpiscono appena 14 miliardi di dollari di esportazioni statunitensi, una cifra decisamente inferiore rispetto ai 450 miliardi di export cinese su cui si abbatteranno le tariffe di Trump.
Oltre al confronto commerciale, la decisione della Casa Bianca si intreccia con una strategia più ampia per influenzare la politica monetaria internazionale. Secondo un documento strategico sulle riforme del commercio globale, il sistema attuale è caratterizzato da un dollaro cronicamente sopravvalutato, una condizione che ha favorito i settori finanziari americani a scapito della manifattura. La forza del dollaro ha reso più convenienti le importazioni, penalizzando le esportazioni e contribuendo alla chiusura di migliaia di stabilimenti produttivi negli Stati Uniti. L’idea dell’amministrazione Trump è che i dazi, se accompagnati da un adeguato aggiustamento del tasso di cambio, possano spostare il peso economico sulle economie colpite, riducendone il potere d’acquisto senza generare inflazione interna. Esperienze passate, come quella del biennio 2018-2019, hanno dimostrato che la svalutazione della moneta nei Paesi colpiti dai dazi può compensare in parte gli effetti economici negativi sulle imprese e sui consumatori americani. Per evitare un impatto eccessivamente brusco sui mercati e per consentire alle aziende di adeguarsi, l’amministrazione Trump prevede un’applicazione graduale delle nuove tariffe. Invece di imporre da subito un dazio del 60% sui prodotti cinesi o del 10% su quelli di altri Paesi, il piano potrebbe prevedere aumenti progressivi, con un incremento del 2% al mese, per dare alle imprese il tempo di riorganizzare le proprie catene di approvvigionamento. Oltre alla gradualità, un altro elemento chiave della strategia è l’introduzione di dazi differenziati in base alle politiche commerciali e valutarie dei singoli Paesi. I partner commerciali degli Stati Uniti saranno suddivisi in diverse categorie, valutando fattori come il livello delle tariffe imposte sui beni americani, le pratiche di manipolazione valutaria, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e il contributo alle spese per la difesa comune, ad esempio nel quadro della NATO. Saranno presi in considerazione anche elementi di natura politica e strategica, come il grado di allineamento con gli Stati Uniti nelle organizzazioni internazionali e il comportamento nei confronti di Paesi rivali come Cina e Russia. L’obiettivo di questa strategia è incoraggiare gli alleati a ridurre le proprie tariffe e adottare politiche commerciali più favorevoli agli Stati Uniti, in modo da ottenere un trattamento più equo per le imprese americane.
Ma l’aspetto più innovativo e controverso della politica commerciale di Trump è il legame diretto tra commercio e sicurezza nazionale. Secondo il governo americano, il sistema attuale ha permesso a molte economie di beneficiare della protezione militare americana senza contribuire equamente ai costi della difesa. L’amministrazione Trump intende modificare questa dinamica, condizionando l’accesso al mercato statunitense al supporto delle strategie geopolitiche di Washington. In particolare, il presidente ha avvertito che i Paesi che non collaboreranno potranno essere colpiti da tariffe più severe, un messaggio che sembra rivolto principalmente all’Unione Europea.
Il piano della Casa Bianca prevede inoltre un’azione decisa nei confronti dei Paesi BRICS, e in particolare della Cina e della Russia. Se queste nazioni dovessero decidere di ridurre l’uso del dollaro nel commercio internazionale, Trump ha minacciato dazi fino al 100% sui loro prodotti. Questo intervento non si limita all’ambito commerciale, ma si configura come un vero e proprio strumento per preservare il primato finanziario degli Stati Uniti, contrastando il tentativo di alcuni Paesi emergenti di ridurre la dipendenza dal dollaro e promuovere valute alternative, come lo yuan digitale. Le implicazioni della nuova strategia tariffaria di Trump potrebbero essere profonde e durature, incidendo non solo sulle dinamiche del commercio internazionale, ma anche sugli equilibri geopolitici e sulla politica monetaria globale. Se la strategia funzionerà o meno dipenderà da diversi fattori, tra cui la reazione delle economie colpite, il comportamento dei mercati valutari e il possibile impatto sull’inflazione interna. Tuttavia, appare chiaro che la nuova guerra commerciale voluta dalla Casa Bianca va ben oltre la semplice questione delle tariffe: in gioco c’è una ridefinizione radicale del sistema economico internazionale, con gli Stati Uniti decisi a riaffermare il proprio predominio sia sul piano commerciale sia su quello finanziario attraverso il dollaro.
Bollette e fisco, il Governo prepara nuove misure
Il governo prepara nuove misure contro il caro energia. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che nelle prossime settimane sarà varato un provvedimento per affrontare il rincaro dei prezzi energetici, sottolineando come il passaggio al mercato libero per gli utenti domestici richieda una valutazione, dato che le tariffe risultano più alte rispetto al regime tutelato gestito dall’Arera. Il prezzo del gas è calato a 51 euro al megawattora, ma resta elevato, rendendo necessario un intervento per mitigare l’impatto sulle famiglie e le imprese.
Sul fronte fiscale, il governo ha incassato nella serata di ieri, la fiducia del Senato sul decreto Milleproroghe, che ora passa alla Camera per l’approvazione definitiva entro il 25 febbraio. Il testo ha subito modifiche rilevanti, tra cui la riformulazione dell’emendamento sulla rottamazione quater delle cartelle esattoriali. I contribuenti che avevano perso il diritto alla sanatoria per mancati o ritardati pagamenti potranno rientrare nel piano saldando il dovuto entro il 30 aprile in un’unica soluzione o in dieci rate fino al 2027. Nonostante la pressione della maggioranza, non è stata concessa una nuova proroga per la sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate, che entrerà in vigore dal primo luglio, sebbene il governo abbia già promesso un ulteriore rinvio con un prossimo provvedimento. Salta anche la proroga per il concordato biennale delle partite IVA, stralciata dal testo per mancanza di coperture finanziarie.
Il decreto prevede invece la cancellazione delle multe per i no-vax, una decisione che ha suscitato dure critiche dal Partito Democratico e persino da esponenti di Forza Italia. La Lega, invece, ha ottenuto l’estensione dell’uso del taser a tutti i comuni, anche quelli con meno di 20mila abitanti. Slitta di due anni la consulta dei tifosi nei cda delle società sportive, mentre resta il termine del 31 marzo 2025 per l’obbligo assicurativo delle aziende contro le catastrofi naturali, nonostante diversi emendamenti puntassero a un rinvio fino alla fine dell’anno.
Tra le altre misure, viene sospeso fino al 30 settembre 2025 il requisito della maggiore età per i bagnini, mentre slitta di sei mesi l’entrata in vigore dell’obbligo di etichette informative per i prodotti ridotti nella quantità ma venduti allo stesso prezzo. Infine, la seduta del Senato di ieri ha visto uno scambio acceso tra Matteo Renzi e Giorgetti. L’ex premier ha ironizzato sullo stato dell’economia paragonandola al rendimento del Southampton, la squadra inglese per cui il ministro tifa, ultima in Premier League. Giorgetti ha replicato sottolineando che l’Italia “qualche anno fa era proprio come il Southampton”, ma grazie alle misure del governo “i risultati su spread e fiducia sono migliorati”.
Perdura il calo della produzione industriale italiana
La produzione industriale in Italia ha registrato un calo del 3,5% nel 2024 rispetto all'anno precedente, segnando il peggior risultato dalla crisi economica del 2008-2009, fatta eccezione per il periodo della pandemia. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Istat, che fotografano una situazione di difficoltà diffusa nel settore manifatturiero.
Tra i pochi comparti in crescita si segnalano le forniture di energia (+1,1%) e il settore alimentare, bevande e tabacco (+1,8%). Per contro, alcuni settori chiave hanno subito un vero e proprio crollo: il tessile ha perso il 10,5%, mentre la produzione di mezzi di trasporto è scesa dell’11,3%.
Il dato della produzione industriale è particolarmente significativo perché rappresenta circa un quinto del PIL italiano, incidendo direttamente sull’andamento dell’economia nazionale. Il settore, però, è in crisi da tempo: negli ultimi 23 mesi consecutivi la produzione è sempre calata. Solo a dicembre 2024, il declino è stato del 7,1% rispetto allo stesso mese del 2023, il peggior risultato degli ultimi due anni.
L’industria italiana, quindi, continua a lottare contro una congiuntura economica sfavorevole, con prospettive che restano incerte per il 2025.